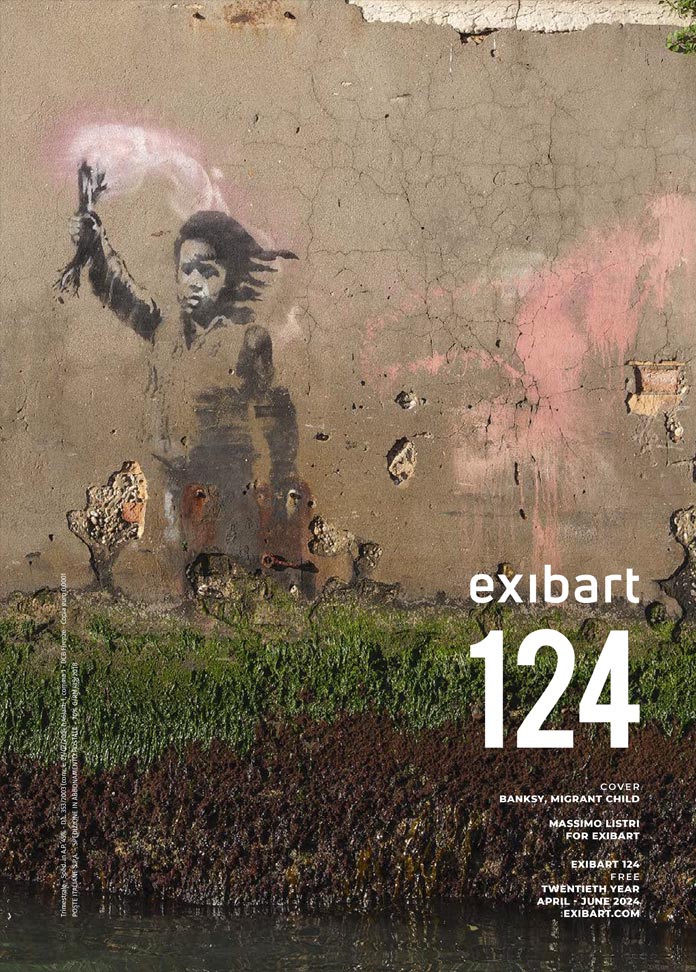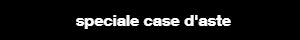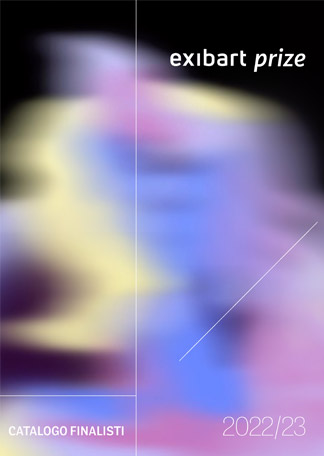Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
07
dicembre 2018
“Amalassunte”, Demoni e altre poesie
Progetti e iniziative
La Collezione Guggenheim di Venezia omaggia con una grande mostra Osvaldo Licini. Approfondendo uno dei più avanguardisti, e straordinariamente classici, artisti italiani
di Luigi Abbate
Che un vento di follia totale mi sollevi. Epitome e proiezione icastica nel titolo della mostra che la Collezione Guggenheim di Venezia dedica a Osvaldo Licini, in occasione dei sessant’anni dalla morte e fino al prossimo 14 gennaio. Espressione che contiene un anelito da Licini profondamente sentito e vissuto nella pratica artistica come nelle scelte di vita: volare, elevarsi in una tensione spasmodica verso un umanissimo assoluto (l’ossimoro è voluto), raggiunto negli esiti celebri delle Amalassunte e degli Angeli ribelli. Raggiunto sì – e quale invidia-ammirazione per l’artista che riesce nell’intento! – ma sempre perseguito con intelligenza coraggiosa, oltre che con inesauribile veemenza. Esiti riconosciuti tardivamente (sono proprio del 1958, anno della morte, l’omaggio alla ventinovesima Biennale e il Premio Presidente della Repubblica). Ed è proprio questo percorso al raggiungimento di quegli esiti il centro dell’attenzione di Luca Massimo Barbero, curatore della mostra veneziana e della stessa Guggenheim Collection. Un percorso che s’inaugura molto presto, nel 1913, Licini solo diciannovenne, a Bologna, per spostarsi ben presto a Parigi, complice il trasferimento dei genitori e una ferita alla gamba. Fin dalla prima sala siamo tuffati in quel clima. Bellissimo l’accostamento di tele quasi coetanee di Licini e dell’allora compagno d’Accademia Giorgio Morandi: forti assonanze di colori pastello, cézanniani, il modellato sensuale delle curve femminili nelle Bagnanti (1915) del secondo come nelle Ballerine (1917) del primo.

Osvaldo Licini, Che un vento di follia totale mi sollevi, visto della mostra, Matteo Delfina
Nel catalogo Marsilio/Guggenheim – da segnalare al suo interno il bel saggio di Federica Pirani (Metafore dell’aria di Osvaldo Licini. Tra memoria e oblio), e un contributo di Sileno Salvagnini sul rapporto fra Licini e la critica d’arte – Barbero riporta un’interessante testimonianza di Mario Tozzi che aveva conosciuto Licini a Bologna proprio insieme a Morandi, e lo rivede al suo arrivo a Parigi: «Avevo lasciato a Bologna un Licini futurista e qui lo ritrovavo postimpressionista». Il Licini futurista, ancora una volta veemente, era stato anche quello dell’autore – pittore/scrittore al pari di un suo modello di allora, Ardengo Soffici – dei durissimi Racconti di Bruto. Un Licini provvisorio come quello figurativo, che sopravvive fino agli ultimi anni Venti. Punta di diamante di quel momento pittorico il ritratto di Nanny, realizzato nel 1926, anno del suo rientro in Italia e inizio del suo ritorno alla nativa Monte Vidon Corrado, borgo marchigiano dove era nato nel 1894 e dal quale d’ora in avanti, a vigile distanza dai centri nevralgici, seguirà fatti dell’arte ed eventi della storia a lui contemporanea. Nanny Hellström è la moglie svedese e nel dipinto, fra il calore della preminenza di ocra e marrone, s’incomincia a intravvedere certa asciuttezza di tratto. Fino alle prime avvisaglie di stilizzazione della figura stessa, riscoperta nelle opere della maturità: Il capro del ’27, erto in mezzo al morbido paesaggio appenninico, richiama alla memoria il rinsecchito toro picassiano, che però compare quasi vent’anni dopo. Le prove “futuriste” liciniane sono precedenti – i Soldati italiani risalgono al 1917 -, e, come avverrà per l’astrattismo, la sua più che un’adesione è un’adiacenza. Geometrie segmentate nelle quali par di percepire l’eco dei timbri corruschi della Seconda Sinfonia di Prokof’ev o di Fonderia d’acciaio di Aleksandr Mosolov (1925/26), ma con il sorprendente effetto di ritrovarli ammorbiditi nella bellissima scelta di colori ad olio tanto tenui da sembrare acquerellati. Musiche, quelle citate, di qualche anno successive al ’17; e di nuovo, senza volerlo, a scoprire, sia pur in un ambito creativo differente, un Licini che anticipa. Ma il focus, e in ciò forse il motivo di maggior interesse critico dell’esposizione veneziana, sta nella particolare attenzione data alla stagione astrattista di Licini, e in particolare nell’aver accostato questa stagione del grande artista marchigiano a quella coeva di Fausto Melotti e Lucio Fontana.

Osvaldo Licini, Che un vento di follia totale mi sollevi, visto della mostra, Matteo Delfina
Astrattismo speciale, quello di Licini: parte integrante, quasi un’unione poeticamente carnale (anche qui un ossimoro cercato) fra la fase astrattista e il corpus dell’intera produzione dell’artista. L’adiacenza storica si spiega, com’è stato giustamente notato, con l’aver sposato, i tre, la scelta astrattista in quanto personale reazione al rappel à l’ordre imposto all’epoca dall’estetica razionalista di regime in Italia. Splendida testimonianza di questa inclinazione, l’Incostante (1932), opera nella quale l’immagine antropomorfica è messa a dura prova da un tratto che si fa sconnesso, apparentemente “illogico”, e della figura resta solo il colore nel fondo rosaceo, forse lontana allusione a un possibile incarnato. È la stessa tinta dell’Aquilone rosa (1935), ed è la stessa pasta di colore di Memorie d’oltretomba (1938) che non solo nel titolo, ma ancor più nel fondo della tela pare evocare atmosfere “parietali”. Ed ecco finalmente alcuni magnifici saggi dell’inclinazione geometrica di Licini che dialogano armoniosamente con le sculture astratte di Melotti e di Fontana. Accomuna i tre grandi artisti anche la milanese Galleria del Milione, dove si ritrovano attorno al 1935, e quindi di nuovo insieme nella torinese prima edizione della “Collettiva d’Arte astratta”. Una stagione circoscritta nel quinquennio 1932-37. Condivisibili le parole di Elena Pontiggia, che coglie «una vocazione linearista che prosciuga le masse dall’interno»; vocazione che sarà marcante e persistente in tutti e tre, seppur in forme ben differenti. Vocazione che, aggiungo io tentando di individuare analogie linguistiche con il comporre musicale, si spinge in Licini come in Melotti e Fontana nella medesima direzione dell’essenzialità aforistica di segno weberniano, naturalmente in forme e con esiti ben distanti l’un dall’altro. Se infatti è vero che – e qui è il mentore Giuseppe Marchiori che parla – l’astrattismo di Licini è «lontano dalle sublimi speculazioni platoniche» al punto da abbracciare derive di natura sinestetica: Assaggiare e Addentare, del biennio ’34-’36, è altrettanto innegabile che sia in grado di manifestarsi con precisione certosina e controllo magistrale degli equilibri cromatici, come nelle Archipitture. In mezzo a queste tensioni, una frase, memorabile, dello stesso Licini: «Dubitare non è una debolezza, ma un lavoro di forme».

Osvaldo Licini, Che un vento di follia totale mi sollevi, visto della mostra, Matteo Delfina
Ulteriore passo in avanti verso i già evocati esiti dell’umanissimo assoluto, sono le “scritture enigmatiche”. L’espressione si trova in una lettera scritta nel 1941 allo storico delle religioni Franco Ciliberti da un Licini sempre più sensibile alla primordialità, ai principi primi ed ultimi dell’essere. Siamo all’incirca negli anni
dell’Olandese volante azzurra, dove, nell’esplicita allusione al titolo dell’opera wagneriana, si palesa una delle tre categorie nelle quale Licini si riconoscerà, quell’errante, che insieme all’erotico delle Amalassunte e all’eretico degli Angeli ribelli rappresenta la sostanza di tutto il suo mondo, della sua arte. Enigmatiche dunque le cifre che rimodellano i tratti del volto, non numerologia cabalistica ma gusto sapido per la forma del numero stesso. Allo stesso modo enigmatica la C che, estranea a ogni necessità di significazione, pure si scioglie in gusto e gioia della pura forma. Enigmatica l’antropomorfizzazione dell’oggetto pittorico (la mano/occhio/bocca/piede de La grande amica n. 2, del 1948-50) ed enigmatico il cuore rosso che compare qua e là. E con il cuore enigmatica pure la luna, stagliata nel blu-notte, quello stesso “blu dipinto di blu” che mi piace immaginare abbia pensato anche un pugliese spacciato per siculo cantando un motivo che da Sanremo si sarebbe sparso per il globo terracqueo, immortale, proprio nell’anno della morte di Licini.
Ed è così che si arriva all’ultima fase, di nuovo, gli esiti sublimi delle Amalassunte, accompagnate da ironiche sigarette in bocca, ammiccanti nella sensualità delle curve.
La nota definizione di errante, erotico, eretico che Licini aveva vergato su un registro in un ristorante di Burano dopo un pranzo in compagnia di Marchiori rappresenta l’ellissi della sua singolare orbita artistica. Ellittico in ogni senso e in ogni direzione, Osvaldo Licini. Lo si diceva, nei confronti del futurismo e poi dell’astrattismo. Perfino del surrealismo, avvicinato non ossequiosamente attraverso la lectio di Breton, ma guardando alle origini, ai lautrémontiani Chants de Maldodor.
La mostra accompagna il visitatore con discrezione, per poi lasciarlo nelle ultime sale a tu per tu con l’artista, e permettergli così di immaginare una sorta di rapporto mistico, cioè senza mediazioni, con le ultime composizioni. Da citarne almeno tre, due delle quali immerse nell’apnea cromatica del blu licinano: l’Angelo ribelle su fondo blu cupo (1956), con le sue inquietanti, pare studiatissime, craquelures, e l’Angelo ribelle del ‘58, che costituisce insieme con il precedente (1951) Crepuscolo della sera un vertiginoso compendio di segni, simboli, richiami e proclami liciniani.
Luigi Abbate