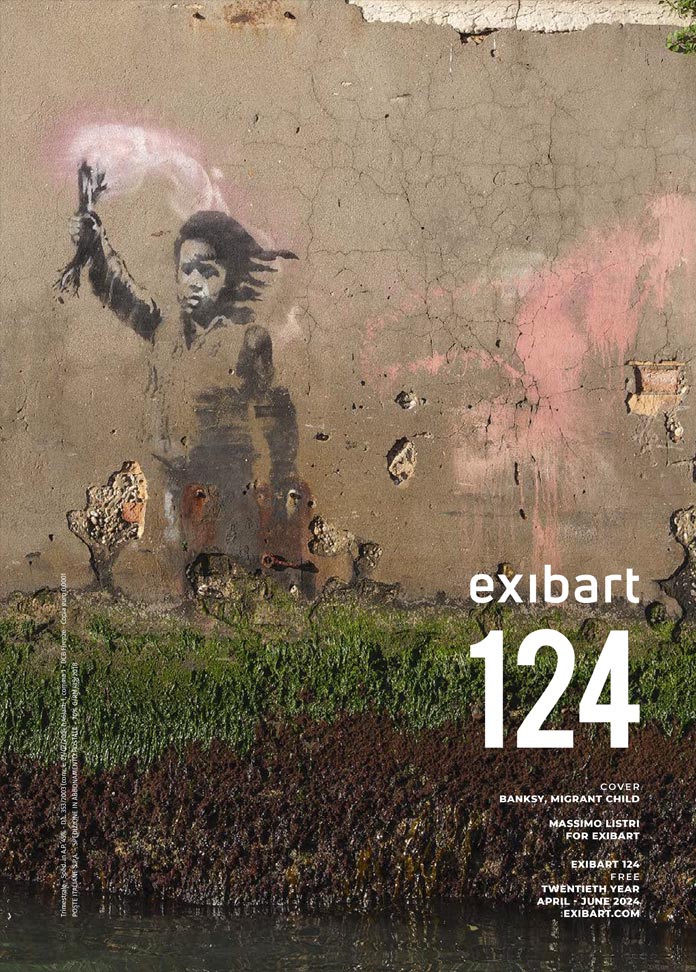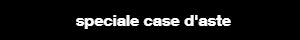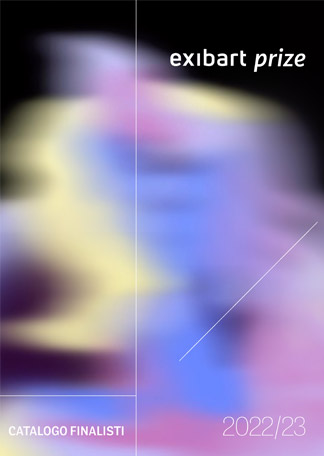Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
03
giugno 2017
Benvenuti da Guidi & Schoen
Progetti e iniziative
Un trasloco e una collettiva di nomi noti, da Accardi a Zorio: dopo quindici anni la galleria genovese ha cambiato sede. Ecco il “Welchome” dei padroni di casa
Ha macinato strada, catalizzando in tre lustri un buon novero di artisti contemporanei di valore. Ha lavorato sodo per conquistarsi ciò che ogni galleria d’arte anela: un nome. Essere in Vico Casana o nella nuova sede di Piazza dei Garibaldi è una questione di poche centinaia di metri che non cambia la sostanza, la galleria Guidi & Schoen – o semplicemente “la Guidi & Schoen”, come si è soliti chiamarla qui a Genova – non ha bisogno di presentazioni.
Per il grande capo Cico Schoen la sede storica aveva fatto il suo, con tutti i limiti del caso. Urgeva una location più performante per nuovi progetti. Proprio come quella che d’ora in avanti sarà la nuova “casa” di Guidi & Schoen, un habitat su più altezze, a detta di Schoen «Uno spazio più versatile, che permetterà di avere più eventi in contemporanea». Di base due piani, due spazi distinti decisamente agli antipodi, col superiore/d’ingresso patinato, elegante e pulito come si confà ad una galleria “stellata”. E – qui viene il bello – un inferiore più caratteristico, a sua volta articolato in diversi livelli; nientemeno che recupero di un’antica cisterna, esempio delle superfetazioni moderne (o relativamente moderne) edificate su fondamenta tardo medievali, un mélange architettonico in realtà abbastanza tipico per chi conosce un po’ i palazzi del centro storico genovese. Disporre di un sotterraneo così ti fa fare fa bella figura a prescindere, anche fosse vuoto; e pure se le sue pareti grezze vengono ricoperte di un bel grigio quasi più votato all’ingentilimento blasé (o, proprio nella peggior ipotesi, a scimmiottare inutilmente l’atmosfera da “loft in centro” del piano superiore), che a far valere secoli di storia.
Per battezzare il nuovo ambiente ci voleva un “benvenuto del gallerista” di un certo spessore. Un WelcHome (fino al 21 luglio), collettiva inaugurale e congiunturale tra la “vetero-contemporaneità” e la “neo-contemporaneità”. Pensiero pilota è «Partire dall’arte contemporanea di riferimento, creando un filo tutto italiano, un contatto tra l’arte del “presente” e quella del “passato”», così Cico Schoen sceglie di raccontarci questa sua nuovissima creatura, da gallerista coi piedi per terra, cosciente di non poter avere manie di grandezza e di dichiararsi «Senza troppe pretese, poiché comunque siamo una galleria privata». Una curatela che Schoen s’è spartito con Luca Beatrice, “missing” nel momento festoso dell’inaugurazione (l’ultimo avvistamento lo dava in giro per Venezia; comunque chi ne ha notizie faccia sapere, a Genova non ve n’era traccia). Peccato, c’era da sperare in qualche sua “sparata” magistrale (e lo diciamo bonariamente, pure col gioco di parole, non sia mai s’offendesse), o in qualche dichiarazione al vetriolo elargita con quell’altera cortesia tutta torinese. In mezzo ad una buona fetta di artisti nati tra i Settanta e gli Ottanta – quelli, ricordiamolo, da lui stesso definiti simpaticamente “giovani, carini e mosci” – avrebbe potuto dare gran soddisfazione.
Quei giovani (si, più o meno, gioventù e anzianità in Italia sono concetti labili) che in verità escono a testa alta, e non sfigurano nemmeno se trascinati in siparietti espositivi tutt’altro che da brivido. Questione di spazi a parete – e ruffianeria da gallerista – fanno si che la botta di adrenalina sia già all’ingresso in galleria, nello scontro fra titani tra l’iper-scenografica apocalisse cittadina di Giacomo Costa e Olivo Barbieri, che al contrario porta il paesaggio urbano a chiudersi come un piccolo plastico, un mondo fatato e condito da un controllato fané nella parte alta. Inquietudine cupa e rilassatezza d’ascendenza fiabesca, Costa che si fa sempre più apprezzare – peraltro con un lavoro recentissimo – e un mostro sacro su cui c’è poco da aggiungere, un dialogo certo non è messo lì a caso, e che lo stesso Schoen ci indica come «fortemente cercato». What else?
In verità Costa-Barbieri anche è il punto più alto, non replicato certo da un acquerello di Luigi Ontani e uno scatto magnetico del talentuoso Matteo Basilé che si guardano in cagnesco. L’apice, benché poco più in là facciano capolino i nomi di Alighiero Boetti e Gilberto Zorio, affiancati da un’imponente e perfetto scatto balneare di Massimo Vitali, in un trio che sta insieme più per comunanza nei toni pastello – distintamente tradotti – che altro. Stesso discorso per il cemento su tela di Enzo Cacciola, la gestualità greve di Marco Gastini, e una bella gouache su carta dell’82 del transavanguardista Mimmo Paladino: stanno bene insieme, sono nomi importanti e nulla più.
Verve a singhiozzo, poco dinamismo cercato negli accostamenti e, nota dolente, pezzi dei cosiddetti “storici” non tutti al top; dall’altra parte “giovani” di talento, come Andrea Chiesi ed Alessandro Lupi, che soffrono collocazioni poco entusiasmanti e un’illuminazione – e siamo già al piano inferiore – da rivedere (godersi vis a vis il piccolo olio di Chiesi equivale a fargli ombra; Lupi, presente con due lavori, pare in entrambi i casi quasi abbandonato a sé stesso). Sempre lì in zona merita l’incontrano coi protagonisti della Nuova scuola romana, da Gianni Dessì, a Pizzi Cannella, a Marco Tirelli primo della classe con le sue volumetrie incantatrici, in un pezzo tonalmente un po’ cupo, ma indiscutibilmente carico di spessore pittorico.
I lettori ci perdoneranno l’aplomb da profanatori di professione, ma con certi nomi e tali possibilità di match avremmo preferito ancora un po’ più di dinamismo, di sano dialogo generazionale. Utile se non altro a scongiurare l’ingresso in quella specie di “cripta d’arte contemporanea”, alias “reparto geriatrico”, costituito da Mario Ceroli (un bel pezzo in realtà, a cominciare dal pino di Russia grezzo e pieno di schegge), da un Frattale di Michelangelo Pistoletto (la parte più povera del poverista di Biella); da Carla Accardi (due sculturine dipinte del 1984, emblematiche di un linguaggio ai tempi già “spompo”), e Giuseppe Uncini (e si, i suoi cementi tengono botta, anche se recenti).
Chi sta meglio di tutti alla fine è il buon Salvo, con un piccolo paesaggio ad olio d’ultima produzione in posizione solitaria e ben evidenziata dietro il desk, di un anacronismo fuori dagli schemi persino nella pomposità della sua cornice. Sa di casalingo, di calore, di una ricerca rigorosa che tra cromatismi e figurazione non chiede troppe spiegazioni. Di benvenuto insomma.
Andrea Rossetti